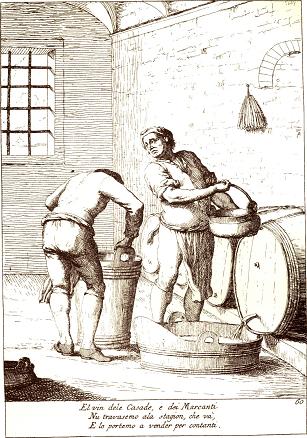
|
| Gaetano
Zompini (1700-1778), "Travasadori de vin". |
|
Tra calli, calli larghe, rami,
corti, sotopòrteghi, ponti e fondamenta, sono ventisette le località che
portano questo nome: 9 nel sestiere di San Marco, 8 a Castello, 5 a
Cannaregio e San Polo.
Questo toponimo ricorda la presenza un tempo di una malvasia,
ovvero di un'osteria che vendeva esclusivamente vino navigato,
cioè trasportato per mare, con esclusione quindi del vino proveniente
dalla terraferma.
Il nome deriva da Monemvasia, un porto fortificato situato nel
Peloponneso, nella regione di Morea, dove i mercanti veneziani nel 1247
erano riusciti ad ottenere l'esclusiva della vendita in tutta l'Europa dei
vini che vi si producevano.
Nelle malvasie veneziane non si trovava solo l'omonimo vino, ma per
estensione tutti i vini che giungevano per mare, in particolare dalla
Grecia, ma anche dal meridione d'Italia, e non solo: si trovavano il
romania, il ribolla, il trebbiano, l'eleatico (aleatico), il cipro, il
malaga, il samos, eccetera.
Erano vini di una qualità superiore rispetto al vino che si trovava nei magazeni
(taverne) ed anche la clientela era diversificata, appartenendo ad ogni
ceto della popolazione.
Tre erano i gusti principali dei vini malvasia (intesi nel senso di vini
navigati): il dolce, che in genere era il preferito dai
forestieri, il tondo, da un gusto piuttosto scialbo e leggero, ed
il garbo, dal gusto forte tendente all'amaro delle mandorle, che
era il preferito dai veneziani.
Il garbo, con dei biscottini, costituiva la colazione degli
elettori del Doge, quando si riunivano per l'elezione. Era anche
usato per la celebrazione della Messa.
I gestori delle malvasie non potevano somministrare pasti ai clienti, né
distribuire carte da gioco o dadi, né innalzare insegne; evidenziavano
così il loro locale esponendo fuori della porta festoni, rami d'alloro e
frasche.
Spesso accanto alle malvasie aprivano delle furatole, bottegucce
che non vendevano vino, ma dove si poteva mangiare qualcosa a poco prezzo,
come minestre, trippa, frattaglie.
|