|
E' reato introdurre nei confini
dello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione francobolli
contraffatti, anche non in corso, ma che hanno avuto corso legale,
emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri.
|
|
|
|
Questa
falsificazione venne realizzata a L'Aquila dove venne spacciata nel
novembre e dicembre 1863.
Il falsario, che in precedenza aveva operato a Napoli con le sue imitazioni, venne scoperto e processato. |
|
|
|
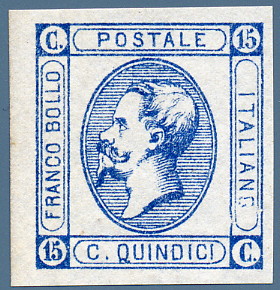
|
Litografico
cent. 15 I Tipo.
Sassone n. 12
Unificato n. 12
Cei n. 7
Bolaffi (numerazione 1956) n.7
Bolaffi (numerazione 1986) n. 65
Bolaffi (numerazione 2002) n. 67A
|
|

|
Falso.
Sassone n. F8
Unificato n. 8F
Cei n. F7g
Bolaffi (numerazione 1956) n. 7FPh
Bolaffi (numerazione 1986) n. 65 (7FPh)
Bolaffi Forum n. 67AFPc
|
|
| |
|

|
| A
destra il nuovo valore da 15 centesimi stampato in litografia che
riprende il precedente francobollo da 20 centesimi ("IV emissione
di Sardegna") stampato in tipografia, qui sopra a sinistra. |
|
Prima di parlare del francobollo da 15
centesimi di Vittorio Emanuele II, detto "litografico", oggetto di
questa falsificazione, è
opportuno fare un cenno alle ragioni che hanno determinato alla sua
emissione.
Aiuteranno a capire alcune cose.
Due sono principalmente i motivi: uno di carattere tariffario, l'altro
legato alla stipula di un nuovo contratto per l'appalto dei valori bollati.
Subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia si sentiva l'esigenza di
uniformare le tariffe postali che, nei vari Stati preunitari, erano le più
varie: per una lettera fino a dieci grammi si passava dal porto di 20
centesimi (ad esempio nell'ex Regno di Sardegna) ai 10 centesimi che erano
richiesti in Toscana ed in Sicilia, per non parlare dell'ex Regno di Napoli
dove circolava ancora la moneta borbonica.
Al termine di lunghe discussioni si stabilì in 15 centesimi la tariffa per
la spedizione di una lettera e la legge relativa, la numero 604, venne
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 125 del 5 maggio 1862.
La nuova tariffa sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1863.
A quel tempo l'appalto per la fornitura dei francobolli era in mano a
Francesco Matraire, litografo di Torino, che dal 1851 aveva stampato tutti i
francobolli del Regno di Sardegna.
L'appalto del Matraire era in scadenza ed erano in corso trattative per
affidare ad una nuova impresa la stampa dei francobolli e delle marche da
bollo. Tra tutti i concorrenti in lizza erano restati per i francobolli il conte Ambjörn
Sparre, consociato nell'affare con i fratelli Pellas di Genova, e la Thomas De La Rue & Co. di Londra per le marche da
bollo.
Da un lato il conte Sparre chiedeva dilazioni dei tempi trovandosi in
affannoso ritardo, dall'altro la De La
Rue, che aspirava a divenire fornitrice anche dei francobolli approfittando
dei ritardi dello Sparre, non era in grado di fornire per tempo le marche da
bollo essendo stata interpellata dal Governo italiano solo nell'ottobre
1862.
Ci si rivolse quindi al Matraire, facendo leva sul suo patriottismo,
affinché «...l'Amministrazione non resti priva dei francobolli necessari
al servizio per il primo trimestre del prossimo anno...».
Così il Matraire, che già stava allestendo le marche da bollo, si prese
carico anche della fornitura del nuovo francobollo da 15 centesimi che
copriva la nuova tariffa che sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1863.
Non aveva certamente il tempo di pensare a nuovi soggetti, doveva lavorare
in velocità (non dimentichiamo che tra tutti i lavori che aveva in corso
c'era anche quello del segnatasse da 10 centesimi) e così si risolse di
aggiornare la cornice usata per la cosiddetta "IV emissione di
Sardegna" con il nuovo valore di centesimi 15.
Questo francobollo, che uscì per tempo il 1° gennaio 1863, non venne
stampato tipograficamente ma in litografia.
Sebbene il Matraire fosse maestro nella preparazione delle pietre
litografiche, la confezione di questo francobollo risultava laboriosa
perché richiedeva il doppio passaggio della stampa e dell'impressione in
rilievo dell'effigie del sovrano.
Nel "Bullettino postale" n. 1 del gennaio 1863 edito
dall'Amministrazione postale troviamo scritto: |
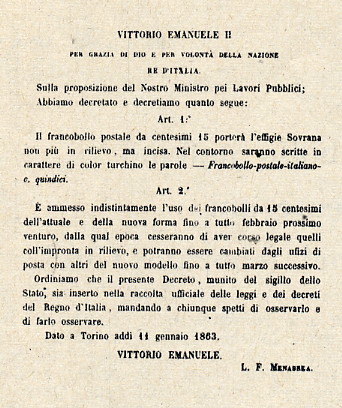
|
| Il
decreto di emissione del 15 centesimi litografico. |
|
«Lo
straordinario aumento nello spaccio dei francobolli da centesimi 15 che si
verificò fin dai primi giorni di gennaio in seguito all'applicazione
della nuova legge che favorisce la francatura, e la difficoltà di
sopperire alle sempre crescenti domande coll'attuale metodo di
fabbricazione che esige un doppio lavoro, quello cioè della incisione del
contorno, e l'altro dell'impressione a secco dell'effigie del re, che non
può farsi collettivamente a molti francobolli ma ad uno solo per volta,
hanno consigliato il Ministero a sostituire alla impronta in rilievo, ora
esistente, l'effigie sovrana colla leggenda ai lati dicente: francobollo -
postale - italiano - c. quindici.
Tale innovazione però ha luogo solamente pel francobollo da centesimi 15
di color turchino, ed in via del tutto provvisoria, dovendo questo seguire
la sorte di tutti gli altri che ora sono in uso eccezionalmente in virtù
del R. Decreto 30 novembre decorso».
Questo portò quindi alla realizzazione del nuovo francobollo da 15
centesimi, impresso esclusivamente con la tecnica litografica.
Stampato in fogli da 200 esemplari, venne distribuito agli uffici in fogli
da cinquanta.
La sua emissione venne decretata dal Regio Decreto n. 1101 dell'11 gennaio
1863.
Questo francobollo è sempre stato considerato un po' come una
"Cenerentola", soffocato da un lato dall'interminabile serie
cosiddetta "IV di Sardegna" e dall'altro dalla nuova ed elegante
serie De La Rue: venne criticato già al momento dell'emissione ed in
seguito anche dai collezionisti.
Eppure non mancò chi ne fece le lodi, scrivendo che «... esso può
essere considerato una autentica innovazione, dal momento che sacrifica
ogni elemento estetico a una esasperata funzionalità (...) Una
semplicità fin esagerata, una leggibilità assoluta, essenziale,
inconfutabile; un francobollo da usare, non da guardare, concepito e
realizzato per l'esclusiva funzione cui è chiamato; un ottimo esempio di
"industrial design" ante litteram.»
Nonostante i cataloghi non lo evidenzino, questo francobollo a ben diritto
potrebbe fregiarsi del titolo di essere stato il primo francobollo del Regno d'Italia, e non solamente per il fatto di recare sulla cornice
l'indicazione «FRANCOBOLLO POSTALE ITALIANO». Fermo restando che
la prima serie concepita come rappresentativa della nuova entità statuale
resta quella detta "De La Rue". |

|
| Il
15 centesimi litografico "secondo tipo". |
|
Se
si eccettua il segnatasse emesso il 1° gennaio 1863 (che, d'altra parte,
era un "segnatasse" e non un "francobollo", nel senso
etimologico delle parole) dalla proclamazione del Regno d'Italia
(convenzionalmente fissata nel 17 marzo 1861) fino a quel momento erano
stati utilizzati i francobolli del precedente Regno di Sardegna, con
l'esclusione delle Province Napoletane dove erano stati introdotti fino a
metà ottobre 1862 degli
appositi francobolli con il valore espresso in moneta borbonica.
Anche l'uso di munire alcuni di quei francobolli sardi di una perforazione
per agevolarne la separazione fu a carattere temporaneo e sperimentale e
non cambiò la tipologia del francobollo che restava quello del precedente
Stato sardo.
Il 15 centesimi emesso il 1° gennaio 1863 non può essere considerato un
nuovo francobollo, ricopiando pedissequamente il precedente valore da 20
centesimi in uso nel Regno di Sardegna dal luglio 1855.
Questo francobollo non ha una data precisa di emissione: al momento l'uso
più antico conosciuto risale al 10 febbraio 1863 (Brescia); fino a non
molti anni fa la data più antica nota era quella dell'11 febbraio e
faceva scrivere ad Enzo Diena nel 1963 che «... è ormai improbabile che
se ne possano trovare di anteriori.»
Intanto sul fronte dell'appalto della stampa delle carte valori, il conte Sparre
aveva chiesto un'ulteriore dilazione fino a tutto il mese di febbraio.
Si giunse così alla risoluzione di quel contratto mentre si infittivano i
contatti con la Thomas De La Rue & Co. per l'affidamento della stampa
dei francobolli.
Venne quindi sottoscritta una nuova convenzione con Francesco Matraire
affinché continuasse la somministrazione dei francobolli fino a quando
non fosse pronta la nuova serie definitiva concedendo anche una
retribuzione extra agli operai «... per ogni notte trascorsa al lavoro».
Ma Matraire pensava di aver terminato il proprio lavoro: aveva stampato i
francobolli necessari per il periodo prefissato, dopo il quale avrebbe
dovuto provvedervi il nuovo appaltatore.
C'è chi dice che avesse cancellato le pietre litografiche che erano
servite per la stampa e per far fronte al nuovo ordinativo dovesse
approntare delle nuove pietre. Forse gli era restata solo la pietra madre,
sulla quale il disegno si era troppo seccato per il non uso. Così per
fare i riporti dovette rigenerarla ed intervenire con correzioni e ritocchi nel disegno.
I nuovi francobolli stampati presentano pertanto delle non trascurabili diversità
che portarono i filatelisti a distinguere questi dagli altri dividendoli in due tipi.
La prima data d'uso attualmente nota per il secondo tipo è del 16 aprile
1863 (Novara).
Il disegno di questo francobollo, di una disarmante semplicità, attirò
l'attenzione dei falsari. |
|
|
La
prima falsificazione cominciò a circolare già nell'aprile 1863 (a soli
due mesi dalla comparsa del francobollo negli uffici postali!) e venne
realizzata litograficamente a Napoli stampando le vignette in foglietti
presumibilmente di 21 esemplari (ma c'è chi sostiene 20).
A giugno, sempre a Napoli, cominciarono ad apparire le falsificazioni
stampate una per una in calcografia.
Ce n'era abbastanza per allarmare il Ministero dei Lavori Pubblici, dal
quale dipendevano le poste, se il ministro dell'epoca si sentì costretto
a scrivere che «... la falsificazione ha preso proporzioni allarmanti e
l'Amministrazione delle Poste è al punto di non poter oltre rispondere
delle sue vendite...» aggiungendo poi che i falsi sono «... un continuo
fomite di immoralità e di colpa.»
Probabilmente si trattava di un'esagerazione, almeno a vedere quanti in
realtà siano i falsi arrivati fino ai nostri giorni.
Resta comunque il fatto che quel falsario, temendo di essere scoperto, si
trasferì a L'Aquila dove si cimentò in una nuova falsificazione che
viene chiamata "falso dell'Aquila".
Per questa imitazione il falsario continuò ad usare il metodo
calcografico ma, mentre a Napoli stampava gli esemplari uno ad uno, ora
pensò di velocizzare il proprio lavoro preparando una lastra di
quattordici vignette (7 x 2) da stampare in foglietti.
I falsi dell'Aquila, che esistono annullati anche a Rieti ed Avezzano, sono facilmente
riconoscibili prima di tutto per il colore: un grigio ardesia, a volte
tendente al bruno.
Evidentemente in origine il
colore doveva essere simile all'originale, ma con il tempo il pigmento si
ossidò deteriorando e prendendo l'aspetto con cui lo vediamo adesso.
Ad un esame attento si vede come i pigmenti più sensibili e meno stabili
si siano degradati trasmutandosi cromaticamente. Persistono tuttavia ampie
tracce azzurre di pigmenti, di natura diversa immune all'ossidazione, che
hanno mantenuto una colorazione vicina a quella originaria. |
|
|
|
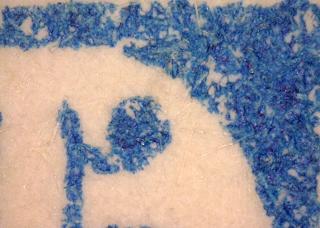
|
| Originale:
il colore azzurro del 15 centesimi litografico è piuttosto uniforme
e brillante. |
|
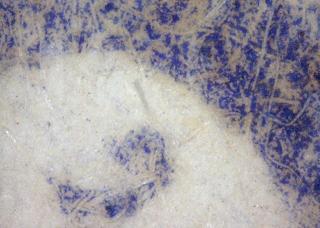
|
| Falso:
alcuni pigmenti hanno resistito al processo di ossidazione, altri
hanno avuto un decadimento di tinta. |
|
|
|
|
|
|
La
stampa calcografica con cui furono realizzate queste imitazioni si
evidenzia illuminando la superficie della carta con una luce radente. Le
caratteristiche della calcografia non sono così evidenti come per le
moderne produzioni a causa, soprattutto, della scarsa qualità della carta
su cui vennero stampati e del trascorrere del tempo.
Tuttavia si possono agevolmente notare nell'immagine qui sotto mettendola
a confronto con quella del francobollo originale (sotto a sinistra) dove si può rilevare la
piattezza e la mancanza di spessore della stampa litografica. |
|
|
|

|
| Originale:
a luce radente si nota, oltre alla buona qualità della carta, la
stampa piatta, tipica della litografia. |
|
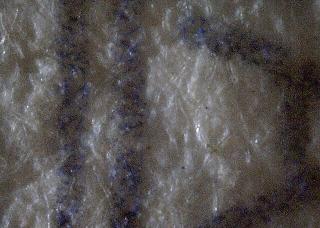
|
| Falso:
a luce radente si evidenzia la scarsa levigatura della carta e lo
spessore della stampa calcografica. |
|
|
|
|
|
|
E' impegnativo dare delle indicazioni
precise su singoli elementi che distinguono i falsi dagli originali, proprio
per il fatto che le 14 imitazioni non erano uguali tra di loro, essendo
state disegnate 14 volte.
In pratica nell'imitazione calcografica dell'Aquila abbiamo 14 tipi diversi.
Ma mentre nei cataloghi sono descritte le sei differenti tipologie di
falsificazioni stampate a Napoli, per i falsi dell'Aquila si astengono dal
fornire simili dettagli.
In genere si può dire che sono soprattutto il colore, la stampa
calcografica ed il disegno complessivamente rozzo ed approssimativo a
distinguere questi falsi dall'originale.
Un altro elemento da prendere in considerazione è dato dalle linee orizzontali
nell'ovale dove campeggia il profilo del sovrano: sono più fitte rispetto
all'originale. Nel francobollo si contano 53 linee di tratteggio (contate a
destra del profilo) che diventano 54 contandole nel lato di sinistra.
Nell'imitazione invece le linee variano (nelle 14 differenti vignette) da 56
a 67: l'esemplare mostrato in alto di questa pagina ha
59 linee orizzontali a destra e 61 a sinistra.
In alcuni falsi dell'Aquila, ma non in tutti, manca ad esempio il punto dopo
la «C» nell'angolo superiore sinistro della cornice (sempre presente nel
francobollo originale). Dovrebbero essere quelli che occupavano la terza e
la quarta posizione nel foglietto.
|
|
|
|
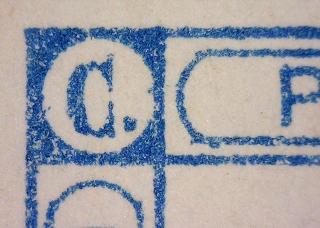
|
| Originale:
il punto è sempre presente dopo la «C». |
|

|
| Falso:
in molti falsi manca il punto dopo la «C». |
|
|
|
|

|
| Una
coppia nuova di falsi calcografici dell'Aquila: quello di sinistra
potrebbe (forse) essere dello stesso tipo di quello mostrato in
questa pagina in alto di
questa pagina. Potrebbe quindi comprendere le posizioni 3 e 4. (da
"Catalogo Bolaffi dei francobolli italiani 1956") |
|
Negli altri falsi il puntino invece
c'è, come in quello qui sotto.

|
| Un
altro falso calcografico dell'Aquila: è diverso da quello preso
in esame in questa pagina. Nell'angolo superiore sinistro della
cornice si può notare la presenza del punto dopo la «C». |
|
La coppia di falsi sotto a sinistra, tratta dal "Catalogo Bolaffi dei
francobolli italiani 1956", mostra due esemplari diversi: quello di
sinistra sembrerebbe essere (il dubitativo è d'obbligo, vista la qualità
dell'immagine) dello stesso tipo di quello usato per questa pagina
(visibile sopra) dove il puntino dopo la «C» è
mancante in alto.
Di tipo diverso sono i due falsi qui sotto, conservati su un frammento ed
annullati all'Aquila il 17 dicembre 1863.
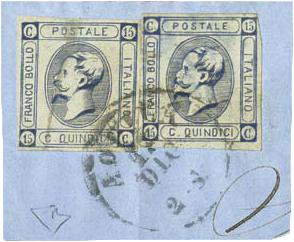
|
| Due
falsi dell'Aquila su frammento annullati il 17 dicembre
1863. |
|
|
|
|
|
|
|
Un altro elemento che accomuna questa
imitazione è la dimensione della scritta «FRANCO BOLLO» sul
cartiglio di sinistra.
Con alcune differenze tra i quattordici tipi, risulta sempre con le lettere
più basse in altezza rispetto alle altre scritte della cornice.
Qui sotto è fatto il confronto tra le lettere «OLLO» di «FRANCO BOLLO»
con le lettere «TALI» di «ITALIANO».
I due gruppi di lettere sono allineati sulla riga rossa. La linea blu
delimita l'altezza delle lettere della scritta «FRANCO BOLLO» mentre
quella gialla si riferisce all'altezza dell'altra scritta. E' evidente la
differenza d'altezza: la scritta «FRANCO BOLLO» è più bassa delle altre
scritte.
Lo stesso raffronto è stato fatto con il francobollo originale
nell'immagine sotto a sinistra: le scritte risultano della stessa altezza.
|
|
|
|
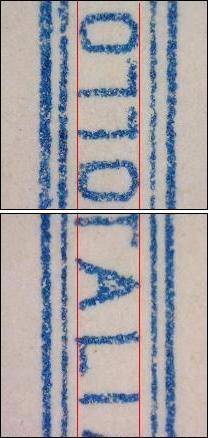
|
| Nell'originale
le lettere della scritta «FRANCO BOLLO» hanno la stessa altezza delle
altre. |
|
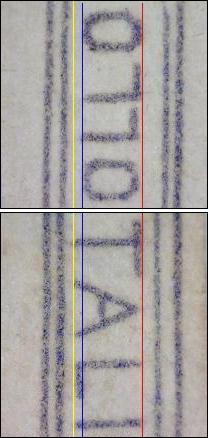
|
| Nell'imitazione
le lettere della scritta «FRANCO BOLLO» sono più basse delle altre. |
|
|
|
|
|
|
Altro elemento di distinzione tra
originale e falso è dato dalla forma dell'orecchio e più in generale della
testa del sovrano.
Nell'immagine sotto, oltre alla differente forma del padiglione auricolare,
si riscontrano differenze nel disegno del baffo, della narice, del profilo
del naso e della fronte. Anche il disegno dei cappelli è risolto in modo
diverso.
Sotto a destra, per confronto, si possono ritrovare gli stessi elementi nel
francobollo originale.
|
|
|
|

|
| Originale:
la riproduzione del volto del sovrano ha dato filo da torcere al
falsario che non è riuscito ad imitare i vari elementi che lo
configurano. |
|

|
| Falso:
non solo l'orecchio, ma anche il profilo del volto ed il disegno del
baffo e dei capelli sono differenti nell'imitazione. |
|
|
|
|
|
|
Il
collo dell'effigie del sovrano termina con una linea obliqua ondulata.
Questa ondulazione, come pure l'area di colore pieno che vuole raffigurare
un'ombra, sono di forma diversa nell'imitazione.
Inoltre nel francobollo originale il vertice del collo tocca la cornice
dell'ovale mentre nel falso risulta nettamente staccata. |
|
|
|

|
| Originale:
l'elemento più difficile da imitare è stata la forma della linea
ondulata alla base del collo. |
|
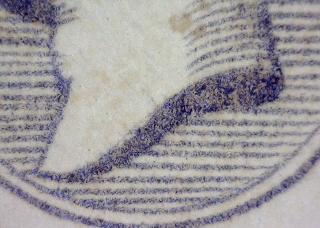
|
| Falso:
la linea che chiude in basso il collo ha un'ondulazione diversa da
quella degli originali. |
|
|
|
|
|
|
Anche
le scritte presentano delle diversità rispetto a quelle del francobollo
originale.
Tali diversità non sono sempre costanti tra tutti i quattordici tipi
dell'imitazione calcografica dell'Aquila.
Interessante in quello che stiamo esaminando la diversa disposizione della
lettera «S» di «POSTALE»: oltre a essere disegnata
inclinata verso destra è anche più alta. Manca inoltre della pancia
inferiore presente nell'originale: l'occhiello superiore ed inferiore sono
infatti, nel falso, quasi simmetrici. |
|
|
|

|
| Originale:
la lettera «S» di «POSTALE» è disegnata in modo regolare. |
|

|
| Falso:
la lettera «S» di «POSTALE» è inclinata a destra ed è più
alta degli altri caratteri. |
|
|
|
|
|
|
Anche
se non è l'unico elemento di distinzione (e forse è il meno attendibile
o, quanto meno, a volte può essere fuorviante) su questo francobollo
l'attenzione dei collezionisti si concentra sulla «Q» di «QUINDICI»
e sulla linea sottostante del cartiglio che racchiude la scritta: questo
è infatti uno degli elementi che distingue il primo tipo dal secondo
tipo.
La «Q», con la sua coda inferiore, è a contatto con la linea
orizzontale del cartiglio (immagine sotto a sinistra). Nell'imitazione
invece (qui sotto) non c'è contatto, anche perché tutte le lettere della
scritta sono di minore altezza. Altre differenze si possono notare sulle altre
lettere: in particolare nella «U», simile ad una «V»,
nella «N», più larga, e nella «D», più stretta e con
la parte destra risolta in un unico tratto curvo. |
|
|
|

|
| Originale:
un tipico elemento distintivo (ma non sempre esatto) per riconoscere
il primo tipo: la lettera «Q» di «QUINDICI» e la linea sottostante. |
|

|
| Falso:
la scritta «QUINDICI» risulta notevolmente diversa
nell'imitazione. Le lettere sono più basse e la forma della «Q»
molto differente, come la sua posizione. |
|
|
|
|
|
|
Come
abbiamo ricordato sopra, i francobolli originali furono stampati in fogli
da duecento esemplari, ma agli uffici postali arrivarono tagliati in fogli
da 50 (10x5).
Le imitazioni furono invece stampate in foglietti da 14 vignette (7x2) su
carta a macchina sottile, di scarsa qualità e consistenza, leggermente
grigiastra.
I francobolli originali ricevettero al verso, dopo la stampa, una gomma
che si poteva presentare come uno strato sottile, quasi invisibile, oppure
più grosso, leggermente scura con una screpolatura più o meno evidente.
La gomma delle imitazioni risulta invece abbondante, lucida, screpolata.
Nell'immagine qui sotto è messo a confronto il verso di un originale (a
sinistra) con quello di una imitazione: anche ad un facile esame ad occhio
nudo si nota la diversità delle gomme. |
|
|
|
|
|
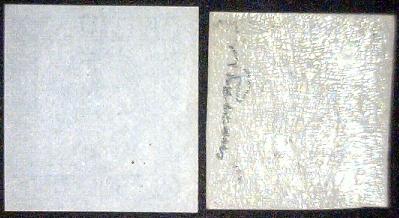
|
| A
sinistra il verso di un originale che ha ricevuto il tipo di
gommatura liscia, sottile, quasi invisibile; a destra la gomma di
un'imitazione stesa più abbondantemente, di tipo lucido con una
sottile screpolatura. |
|
|
|
|
|
|
Il falsario venne scoperto e
denunciato a L'Aquila. Per questo subì un processo.
Esistono varie tipologie di lettere affrancate con questa imitazione
calcografica. Senza andare nel dettaglio, queste possono essere regolarmente
viaggiate senza essere state scoperte (e sono le più rare) oppure risultano
timbrate, ma il francobollo non annullato in quanto scoperte ed intercettate
per identificare il mittente. La maggior parte di queste
ultime proviene dal fascicolo del processo cui fu sottoposto il falsario e
sono ascrivibili al mese di dicembre 1863.
Questa falsificazione si conosce utilizzata anche nel gennaio 1864, quando
il francobollo originale aveva gà perso la propria validità postale.
|
|
|
|
|
|
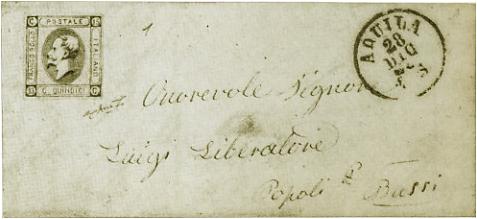
|
| Falso
calcografico dell'Aquila con timbro del 28 dicembre 1863. Il
francobollo non venne annullato perché venne intercettato e
riconosciuta la frode. |
|